349 618 7791
Via Luigi d'Andrea 19 - Crema (CR)
|
Comunicato Studio di Psicologia Crema, 08/03/2020
A partire da domani 09/03/2020 fino al 03/04/2020 o fino a nuove direttive, verrà privilegiata, ove possibile, la consulenza online tramite piattaforme audio/video. Questo al fine di limitare gli spostamenti delle persone, e garantire al tempo stesso la continuità dei percorsi psicologici. Dott. Giorgio Franzosi Psicologo Psicoterapeuta Tel. 3496187791 [email protected] Che cos'è un trauma psicologico?
Il trauma psicologico può essere definito come un'esperienza estremamente grave che compromette il senso di stabilità e continuità fisica e psichica della persona che lo vive.
La parola “trauma” deriva dal greco e significa “ferita”. Chi vive un trauma sperimenta una spaccatura profonda tra un “prima” e un “dopo”. Un prima caratterizzato da routine, sicurezza e serenità e un dopo fatto di paure, angosce e mancato controllo. Esistono due tipologie di traumi psicologici a cui una persona può andare incontro nel corso della vita. Nella prima tipologia rientrano i "piccoli traumi", cioè quelle esperienze soggettivamente disturbanti che sono caratterizzate da una percezione di pericolo non particolarmente intensa. Rientrano in questa categoria eventi quali un'umiliazione subita o interazioni brusche avvenute nell'infanzia con persone significative (ed esempio i genitori). Nella seconda tipologia rientrano i "grandi Traumi", ovvero tutti quegli eventi che minacciano l'integrità fisica propria o delle persone care (ad esempio incidenti, disastri naturali, violenze, ecc.). A prescindere dalla tipologia del trauma, la ricerca scientifica ha riscontrato che le persone dal punto di vista emotivo reagiscono mostrando gli stessi sintomi. Va anche però precisato che non tutte le persone che vivono un'esperienza traumatica reagiscono allo stesso modo. Alcune sono in grado di riprendersi completamente in autonomia e di tornare a una vita normale anche in poco tempo, altre sviluppano reazioni di varia entità che nei casi più gravi impediscono alla persona di continuare a vivere la propria vita come prima dell'evento traumatico. L’essenza della metafora è comprendere e vivere un tipo di cosa nei termini di un’altra. Il nostro linguaggio e la nostra conoscenza del mondo non sono di natura letterale, ma metaforica (Giuliani, 2017). I lavori portati avanti per più di un decennio da George Lakoff e Marc Johnson (1980, 1998, 1999) sul linguaggio metaforico si basano sull’ipotesi che la conoscenza del mondo astratto (idee, eventi, emozioni) e l’immagine che ne costruiamo derivino dalla nostra esperienza del mondo fisico. Per tale motivo la cognizione della realtà è fondamentalmente metaforica: conosciamo il mondo astratto attraverso i concetti con cui abbiamo imparato a conoscere la realtà di cui abbiamo esperienza sensoriale (Giuliani, 2017). Quando per esempio diciamo che abbiamo avuto una giornata di lavoro “pesante”, o che l’ascolto di una canzone ci ha fatto sentire “leggeri”, o che il discorso di un politico ci è sembrato “vuoto”, stiamo attribuendo a cose astratte (lavoro, musica, discorsi) qualità che esperiamo dal mondo sensoriale. Con il termine mentalizzazione ci si riferisce all’attività di comprensione del comportamento in relazione a stati mentali come pensieri e sentimenti.
Mentalizziamo tutte le volte che siamo consapevoli degli stati mentali in noi stessi e negli altri, come per esempio quando pensiamo ai sentimenti. Alcune definizioni pratiche di mentalizzazione possono essere le seguenti: tenere a mente la mente; considerare gli stati mentali propri e degli altri; comprendere i fraintendimenti; vedere se stessi dall’esterno e gli altri dall’interno; attribuire una qualità mentale alle cose o sviluppare una prospettiva mentale. La mentalizzazione è un’attività mentale prevalentemente preconscia (automatica), immaginativa (intuitiva), emozionale (non cognitiva), e aiuta a regolare le emozioni. La mentalizzazione è un costrutto complesso, che include tutto ciò che va da fenomeni come i bisogni, i desideri, i sentimenti, i pensieri, le credenze, le fantasie, i sogni ai processi psicopatologici. Il concetto di ipotizzazione compare per la prima volta nell'articolo del 1980 Ipotizzazione – circolarità – neutralità: tre direttive per la conduzione della seduta e rimanda una specifica linea guida su cui si basa il colloquio clinico ad orientamento sistemico.
L'ipotizzazione si riferisce alla capacità del terapeuta di formulare un’ipotesi fondata sulle informazioni in suo possesso. Attraverso l’ipotesi il terapeuta stabilisce il punto di partenza della propria investigazione con metodiche atte a verificarne la validità e qualora risultasse errata, il terapeuta deve formularne rapidamente un’altra, basandosi sulle informazioni emerse durante il lavoro di verifica dell’ipotesi precedente. Una ipotesi non è mai né vera né falsa, ma solo più o meno utile al lavoro terapeutico. L’ipotesi, inoltre, deve essere sistemica, deve cioè includere tutti i componenti della famiglia e fornire il terapeuta di una supposizione del funzionamento relazionale globale.
La capacità di dire “no” è fortemente correlata a come percepiamo i nostri confini.
Un senso fisicamente sentito dei confini, al quale fare ricorso per aumentare la sensazione di stare bene e di essere al sicuro, è una risorsa essenziale. Un confine rappresenta un limite, una barriera. Tutte le volte che facciamo delle scelte, che diciamo sì ad alcune cose e no ad altre, che ci orientiamo verso alcune persone o situazioni e allontanandoci da altre, stiamo mettendo dei confini. Se abbiamo buoni confini siamo in grado di proteggere noi stessi e di fare scelte coerenti con i propri bisogni, desideri, inclinazioni, ecc. Al contrario, in assenza di buoni confini corriamo il rischio di non essere in grado di fare scelte, di accondiscendere alle richieste degli altri, sopportare violazioni ripetute, porre aggressivamente dei limiti o ritirarci dal contatto. Nei primi anni '50, l'interesse per la comunicazione aveva portato i pionieri dell'approccio sistemico - riuniti presso l'MRI nel così detto "gruppo di Palo Alto - a teorizzare che il sintomo psicologico svolgesse una particolare funzione all'interno del sistema familiare.
Siamo negli anni della cibernetica di primo ordine, in cui la famiglia – oggetto privilegiato d’intervento – era considerata come una macchina cibernetica che si muoveva secondo una logica circolare, e della quale era importante capire come funzionava. Un sistema, secondo la teoria generale dei sistemi, è un insieme di oggetti e di relazioni tra gli oggetti e tra i loro attributi, in cui gli oggetti sono parti del sistema, gli attributi sono le proprietà degli oggetti e le relazioni tra oggetti e attributi sono l’elemento che tiene insieme il sistema.
Quali qualità debba possedere un buon terapeuta è ormai assodato. Molti studi sono stati condotti al riguardo, e anche semplicemente cercando in Google "Come riconoscere un bravo terapeuta" si trovano migliaia di post, scritti da psicologi e altri addetti ai lavori.
Più difficile, invece, è carpire quali caratteristiche debba avere un pessimo terapeuta. Per nostra fortuna questa lacuna è colmata dal geniale Jay Haley, che nell'arguto e pungente Strateghi del potere (1986) ha stilato una serie di accorgimenti da attuare per aumentare le possibilità di fallire come terapeuta. Quella che segue è una sintesi delle migliori strategie da mettere in atto per far sì che una terapia vada nel peggiore dei modi. L'utilizzo del paradosso in terapia è una strategia tipica delle terapie sistemiche, introdotta, sperimentata e perfezionata tra gli anni '50 e '70, ed oggi ancora molto sfruttata dai terapeuti sistemici.
Uno dei primi interventi paradossali con finalità terapeutiche è rintracciabile in Verso un’ecologia della mente (Bateson, 1977). Bateson racconta di una psichiatra, la dottoressa Frieda Fromm-Reichmann, la quale aveva in cura una ragazza schizofrenica che si era rifugiata in un mondo immaginario abitato da potenti dei. |
AutoreGiorgio Franzosi è psicologo psicoterapeuta e terapeuta EMDR. Da diversi anni aiuta a ritrovare il proprio benessere psicofisico nel più breve tempo possibile. Lavora a Crema (CR) e Online. Categorie
Tutti
Archivi
Luglio 2023
|

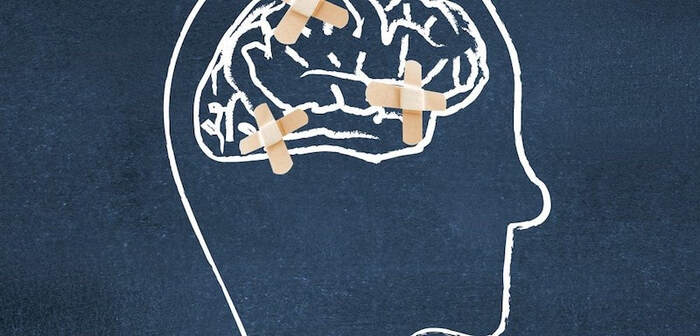
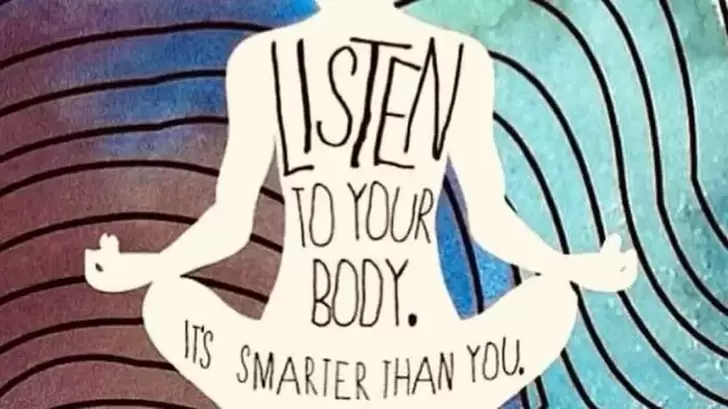

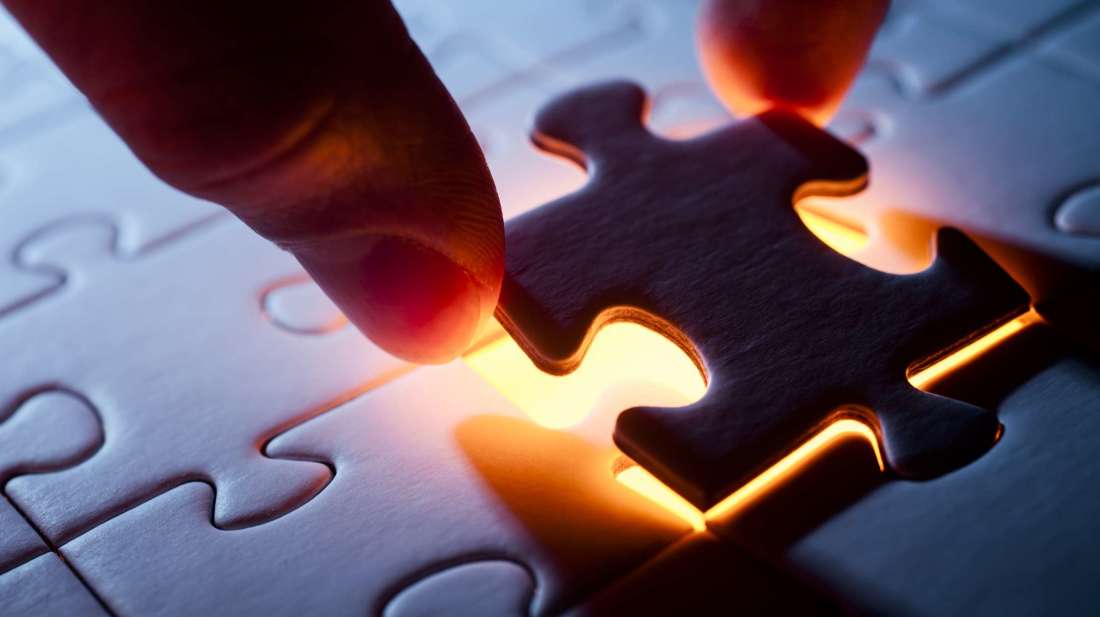

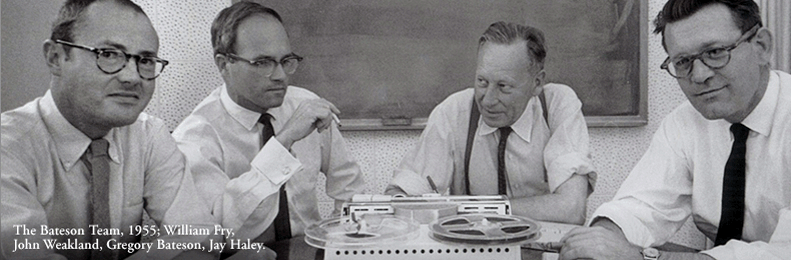
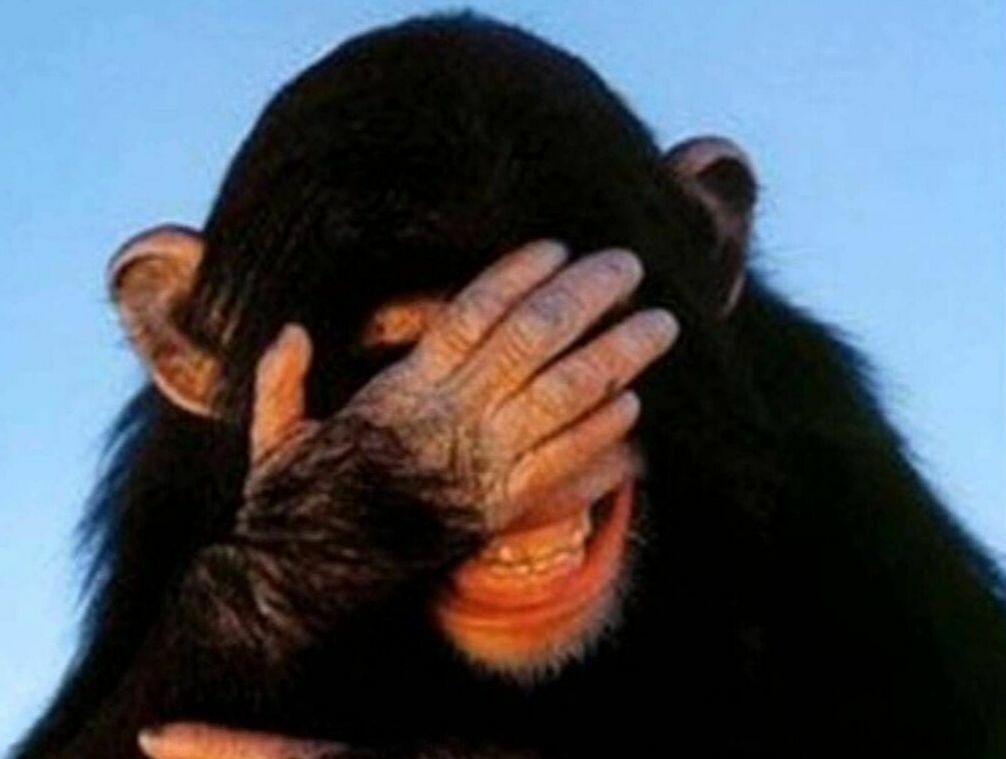

8/3/2020
0 Commenti