|
Il concetto di ipotizzazione compare per la prima volta nell'articolo del 1980 Ipotizzazione – circolarità – neutralità: tre direttive per la conduzione della seduta e rimanda una specifica linea guida su cui si basa il colloquio clinico ad orientamento sistemico. L'ipotizzazione si riferisce alla capacità del terapeuta di formulare un’ipotesi fondata sulle informazioni in suo possesso. Attraverso l’ipotesi il terapeuta stabilisce il punto di partenza della propria investigazione con metodiche atte a verificarne la validità e qualora risultasse errata, il terapeuta deve formularne rapidamente un’altra, basandosi sulle informazioni emerse durante il lavoro di verifica dell’ipotesi precedente. Una ipotesi non è mai né vera né falsa, ma solo più o meno utile al lavoro terapeutico. L’ipotesi, inoltre, deve essere sistemica, deve cioè includere tutti i componenti della famiglia e fornire il terapeuta di una supposizione del funzionamento relazionale globale. Sebbene il concetto di ipotizzazione sia nato in un contesto storico-culturale in cui la terapia sistemica coincideva con la terapia familiare, esso rimane attuale e di fondamentale importanza anche per la terapia sistemica individuale. Nella terapia individuale l’ipotesi rimane sistemica nel senso che la condizione del paziente è letta all’interno del suo sistema di relazioni passate e presenti. Ha funzioni utili per l’assetto di seduta perché orienta l’osservatore, facilita l’attenzione e dà origine all’indagine. L’ipotesi sistemica permette di collocare il richiedente in un sistema di relazioni più ampio che comprenda l’eventuale inviante, i familiari, che colleghi tali relazioni nel contesto in cui si esplicano e che consenta di cogliere l’evoluzione del problema cronologicamente, connettendola ai tentativi di soluzione già adottati. Nella prospettiva sistemica, anche quando il problema è presentato da una singola persona, l’ottica con cui lo si valuta deve essere sempre sovraindividuale, e si muoverà sia sull’asse orizzontale delle relazioni attuali, sia su quello verticale del trigenerazionale. La caratteristica principale dell’ipotesi sistemica, infatti, è quella di pensare all’individuo sempre in relazione, includendo un certo numero di persone che abbiano nel qui e ora, o che abbiano avuto nel passato un significato importante per il paziente. Un sistema relazionale esteso, dunque, che possa andare oltre i membri della famiglia, che contempli altre figure significative, tra cui il terapeuta e altre relazioni sociali in cui è coinvolto (lavoro, scuola, amicizie, ecc.). Nella terapia individuale sistemica, gli altri significativi vengono presentificati principalmente attraverso domande circolari, ma che sono molto diverse da quelle che erano (e in parte sono) utilizzate nella terapia familiare[1]: “La conduzione circolare del colloquio in terapia individuale è qualcosa di molto diverso dalle circular questioning (…) utilizzate in terapia familiare. È resa possibile da una particolare forma di riflessività all’interno della diade, costituita dall’abituarsi a ragionare in termini di ipotesi. (…) È importante riflettere sulla relazione tra domande, pensieri, e risposte. Nella terapia individuale sistemica (rispetto alla familiare) il significato delle domande cambia. Le domande e i commenti in seduta non si aspettano sempre una risposta, più spesso si esprimono in silenzi, nella riflessione e nei collegamenti di ciascuno per tradursi in un’altra immagine o una nuova idea che talvolta genera un’altra domanda, o anche soltanto un’ipotesi. La conversazione terapeutica non è un dialogo tra conoscenti, non rispetta i turni della conversazione rispettosa, non è neutrale e neppure simmetrica” (Cambiaso, Mazza, 2018, pp. 101-102). L’ipotizzazione è un processo che inizia fin dal primo contatto (solitamente telefonico) e attraversa ogni fase della terapia. Anche l’osservazione degli aspetti analogici, posturali, verbali e relazionali, ha una grande rilevanza per la formulazione delle prime rudimentali ipotesi: “(…) ciò che abbiamo di fronte (…) in un primo colloquio individuale è una persona nella sua unicità, con una storia e un funzionamento proprio, un temperamento esclusivo, un modo di atteggiarsi, di abbigliarsi, di scandire le parole con un tono e una ritmicità, un peculiare modo di guardare o non guardare, un particolare movimento oculare, una relazionalità (…) prossemica che individueremo già aprendo la porta, salutando, stringendo la mano, guardandolo dirigersi verso la poltrona con più o meno sicurezza, commentando sullo studio o su di noi. In questa relazione oculare vi è un implicito e un non detto che richiama l’infanzia, la scoperta, l’attenzione con cui la madre (o il padre) guarda e studia i primi movimenti interattivi del cucciolo” (Cambiaso, Mazza, 2018, p.167). La costruzione dell’ipotesi segue le tappe della raccolta di informazioni, trasformandosi da ipotesi rudimentale a ipotesi sempre più raffinata, ripulita e complessa. I passaggi essenziali da considerare per la costruzione delle ipotesi sono i seguenti:
Note [1] Le domande circolari erano state originariamente formulate sul principio della “circolarità”, definita dai suoi fautori come “la capacità del terapista di condurre la sua investigazione basandosi sulle retroazioni della famiglia alle informazioni da lui sollecitate in termini di rapporti, e quindi in termini di differenza e mutamento” (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata, 1980, p. 13). Esse avevano lo scopo principale di mantenere attivo il terapeuta nella costruzione delle ipotesi, fare emergere i pattern relazionali tra i membri della famiglia, stimolare la curiosità e garantire la neutralità (Cecchin, 1988). Bibliografia
Lascia una Risposta. |
AutoreGiorgio Franzosi è psicologo psicoterapeuta e terapeuta EMDR. Da diversi anni aiuta a ritrovare il proprio benessere psicofisico nel più breve tempo possibile. Lavora a Crema (CR) e Online. Categorie
Tutti
Archivi
Luglio 2023
|

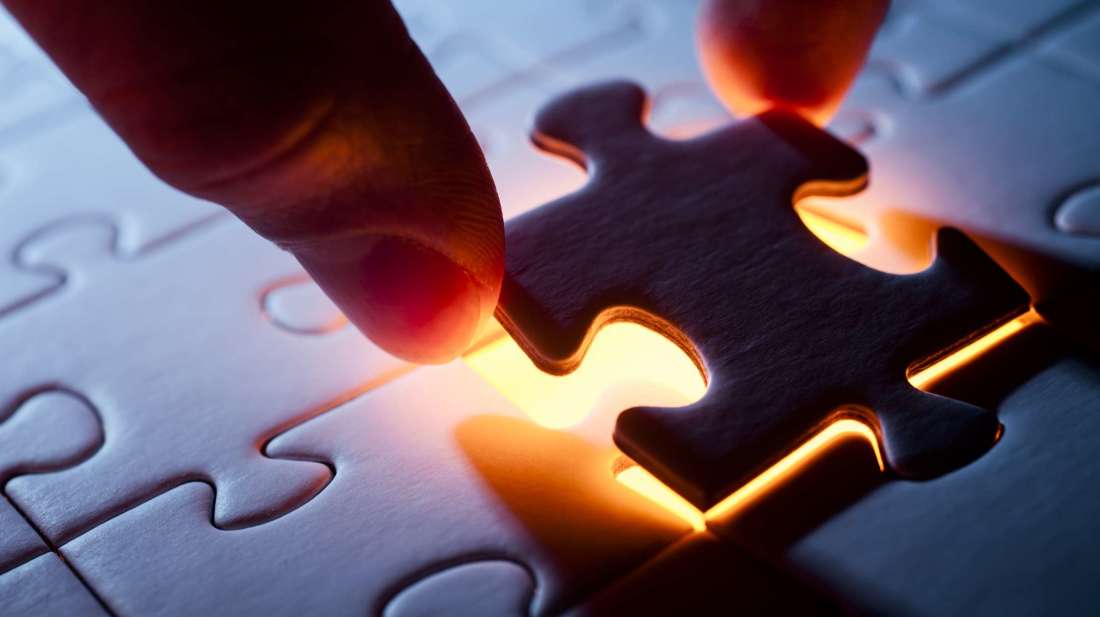
8/5/2019
0 Commenti