|
Nei primi anni '50, l'interesse per la comunicazione aveva portato i pionieri dell'approccio sistemico - riuniti presso l'MRI nel così detto "gruppo di Palo Alto - a teorizzare che il sintomo psicologico svolgesse una particolare funzione all'interno del sistema familiare. Siamo negli anni della cibernetica di primo ordine, in cui la famiglia – oggetto privilegiato d’intervento – era considerata come una macchina cibernetica che si muoveva secondo una logica circolare, e della quale era importante capire come funzionava. Un sistema, secondo la teoria generale dei sistemi, è un insieme di oggetti e di relazioni tra gli oggetti e tra i loro attributi, in cui gli oggetti sono parti del sistema, gli attributi sono le proprietà degli oggetti e le relazioni tra oggetti e attributi sono l’elemento che tiene insieme il sistema. Nel sistema “famiglia”, gli oggetti sono le persone, gli attributi delle persone sono i comportamenti di comunicazione, e le relazioni tra le persone e tra i loro comportamenti di comunicazione tengono insieme il sistema.
I sistemi sono caratterizzati da alcune proprietà, tra cui la totalità, la retroazione e l’equifinalità. La totalità è la proprietà per cui ogni parte del sistema è in rapporto con le parti che lo costituiscono, tale che ogni cambiamento in una parte determina un cambiamento in tutte le parti e in tutto il sistema. Questo significa che all’interno di una famiglia il comportamento di ogni individuo è in rapporto con il comportamento di tutti gli altri membri e che ogni cambiamento nel comportamento di un membro causa un cambiamento nel comportamento di tutti gli altri e dell’intera famiglia. La proprietà della retroazione fa riferimento al fatto che la relazione tra sistema e ambiente è circolare e non causale, (laddove l’ambiente di un sistema è costituito dall’insieme di tutti gli oggetti tali per cui un cambiamento nei loro attributi influenza il sistema e dall’insieme di tutti gli oggetti i cui attributi sono influenzati dal comportamento del sistema). La famiglia, che è un sistema interpersonale, può essere considerata come un circuito di retroazione, in cui il comportamento di una persona influenza ed è influenzato dal comportamento di un’altra persona. Infine, l’equifinalità determina che condizioni iniziali diverse possono dar luogo ai medesimi risultati, così come condizioni iniziali uguali possono determinare risultati diversi. Da tutto questo ne consegue che la famiglia può essere considerata un sistema aperto, autocorrettivo a tendenza omeostatica, in continua interazione con il mondo esterno. Il sistema famiglia ha una rilevanza particolare all’interno dell’orientamento sistemico poiché da un lato la famiglia è per ogni individuo un contesto primario di apprendimento e di esperienza nel quale si sviluppano o falliscono sia i movimenti di individuazione e di differenziazione sia i processi di acquisizione di identità, e dall’altro perché il sistema familiare è un sistema complesso caratterizzato da intersezioni di livelli multipli, in cui il piano sincronico di interazione e di modelli comunicativi si incrocia con il piano diacronico di storie individuali e collettive, di significati, di valori condivisi e di miti. “In principio è la relazione”, recita il primo pregiudizio sistemico, sostenendo l’idea che, nella terapia sistemica, il focus principale di osservazione e di indagine deve sempre essere volto ai contesti relazionali significativi (famiglia, lavoro, scuola, amicizie, ecc.). Ciò significa che secondo la terapia sistemica le relazioni sono costitutive, cioè, dal punto di vista logico, vengono prima degli individui. L’idea qui è che l’individuo non esista dapprima in isolamento, per poi interagire con gli altri nelle relazioni; al contrario, le relazioni sono originarie, e solo in un secondo momento, dalle relazioni è possibile isolare gli individui. Dare importanza alle relazioni non significa mettere tra parentesi gli individui, ma riconoscere la centralità della componente relazionale e interattiva che sta alla base della storia passata, presente e futura delle persone. Lo sguardo è volto alle relazioni tra individui e a partire dalle relazioni si ricostruiscono gli individui. Coerentemente con questo principio, la psicopatologia o il sintomo non sono visti come qualcosa di interno all’individuo, ma come un epifenomeno che emerge da pattern relazionali disfunzionali. In ottica sistemica, per comprendere adeguatamente il comportamento di una persona è dunque necessario osservarlo all’interno del contesto in cui si sviluppa ed entro il quale acquisisce un preciso significato. Questo è uno dei concetti fondamentali dell’approccio sistemico, per cui ogni comportamento umano rimanda ad un contesto e può quindi essere compreso ed eventualmente modificato solo tenendo in considerazione il contesto in cui si manifesta. Quanto affermato è ancor più vero nel caso ci si trovi a cercare di comprendere il comportamento sintomatico di una persona che gli altri considerano e definiscono “disturbata”, “malata” (nella terminologia sistemica il così detto “paziente designato”). I problemi e le difficoltà di un individuo, e conseguentemente anche gli eventuali sintomi che manifesta, sono – infatti – strettamente correlati ai problemi e alle difficoltà del suo ambiente di vita. In questi casi si verificano situazioni altamente complesse, all’interno delle quali il sistema (che di solito coincide con la famiglia del soggetto) segnala uno dei suoi membri come malato per una propria esigenza funzionale. Gli studi compiuti tra gli anni ’50 e ’70 dal gruppo di Palo Alto sulla comunicazione umana identificano nel paziente designato il membro che è stato delegato dalla famiglia a svolgere la funzione omeostatica rispetto al sistema, riportando questo allo stato “originario” ogni volta che nuove informazioni ne minacciano la stabilità. Non solo, ma qualora lo stato di organizzazione disfunzionale del sistema (ossia la presenza di un problema in uno dei suoi componenti) sia messo in discussione da uno qualsiasi dei suoi membri o da fattori esterni, il paziente designato subisce un aggravamento o un incremento del sintomo e questo permette agli altri membri della famiglia di non abbandonare i propri ruoli, col risultato che il sistema non andrà incontro ad alcuna trasformazione o cambiamento. Il sintomo, dunque, esprime la disfunzione del sistema e, contemporaneamente, lo mantiene stabile. Il sistema raggiunge e mantiene l’unità attribuendo il ruolo di capro espiatorio ad uno dei suoi membri, che accentra su di sé tutte le difficoltà comunicative, eliminandole così dal resto del sistema. Il capro espiatorio, a sua volta, trae un vantaggio dal suo sintomo, che è quello di riuscire ad avere il controllo sul sistema. In questa cornice di riferimento, il comportamento sintomatico del paziente è una risposta adeguata e comprensibile all’interno del contesto interpersonale in cui si verifica. Il sintomo, in questo modo, non è più considerato come la manifestazione di una malattia, ma come il prodotto di una relazione tra due o più persone e il comportamento del paziente perde il suo aspetto di incomprensibilità, acquistando invece un significato appropriato alla situazione. In ottica sistemico-relazionale, il sintomo diviene dunque una modalità di interazione con gli altri significativi finalizzata ad assumere il controllo della relazione, talvolta in accordo implicito con altre persone coinvolte nella relazione stessa. Sempre seguendo il filone strategico della teoria sistemica – ed in particolare quello rappresentato da Jay Haley – alla presenza di un sintomo si ha una relazione particolare in cui il paziente “manovra” il comportamento dell’altro e contemporaneamente manifesta che non lo sta facendo, in quanto non ne è lui direttamente responsabile, essendo il sintomo fuori dal suo controllo. Il sintomo fornisce un potere e un vantaggio al paziente, che è proprio quello di ottenere il controllo della relazione, negandolo e adducendo, al contrario, la totale involontarietà del suo sintomo. Questo doppio aspetto del sintomo, da un lato come espressione di una situazione di sofferenza e dall’altro come dispensatore di vantaggi secondari, crea una situazione paradossale per il paziente, da cui per lui è estremamente difficile uscire. Il sintomo, inoltre, è spesso funzionale non solo al paziente, ma anche alle altre persone del sistema in cui emerge e alle relazioni stesse. Secondo l’approccio sistemico, il sintomo è quindi funzione ed espressione non del singolo individuo che lo manifesta, ma di un sistema più ampio, di una situazione interpersonale che coinvolge più persone e all’interno della quale appare come modalità di risposta adeguata a quel sistema in quel contesto. Da un punto di vista relazionale il sintomo, che in passato era visto come una difesa contro un contenuto mentale, può essere definito come un modo di relazionarsi con un’altra persona, acquistando quindi un significato comunicativo. In definitiva, il comportamento sintomatico, che di solito è presentato come il problema, non riguarda solo il soggetto che lo manifesta, ma l’intero sistema, ed è considerato come una risposta ad una situazione, per la quale il sintomo è funzionale. In quest’ottica il sintomo di un paziente non sarà considerato tanto quanto l’espressione di un conflitto psichico di cui si ricercano le cause, ma piuttosto come l’espressione di informazioni scambiate all’interno di un sistema che hanno un certo effetto e una certa funzione su quel sistema, che comprende anche il paziente. Diventa quindi importante analizzare l’effetto del comportamento sintomatico nei rapporti tra il paziente designato e il suo sistema, dal momento che ogni comportamento è un messaggio che risponde ad altri messaggi e che determina nuovi scambi comunicativi. Considerare il sintomo non come interno al singolo individuo ma come epifenomeno che emerge nelle relazioni significative permette di rispondere alla domanda “a cosa serve il sintomo in quel sistema”, cioè di comprenderne il significato e l’utilità. Lascia una Risposta. |
AutoreGiorgio Franzosi è psicologo psicoterapeuta e terapeuta EMDR. Da diversi anni aiuta a ritrovare il proprio benessere psicofisico nel più breve tempo possibile. Lavora a Crema (CR) e Online. Categorie
Tutti
Archivi
Luglio 2023
|

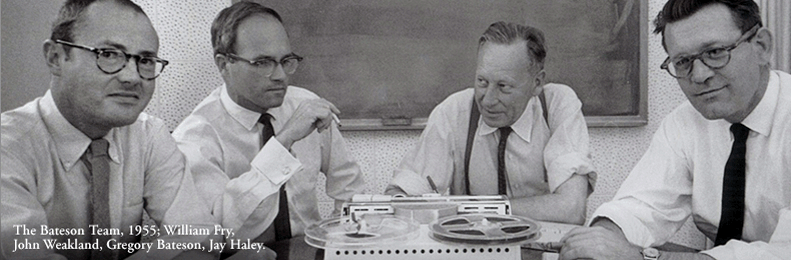
12/3/2019
0 Commenti